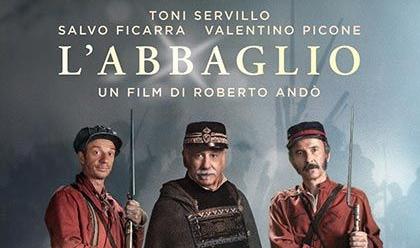Leggilo in 2 minuti
Lo Statuto Albertino e il 20%

Nessuno, o quasi, ricorda più lo Statuto Albertino, che gli italiani cancellarono il 2 giugno 1946. I cittadini vi erano chiamati “regnicoli”, una parola che a me ha sempre fatto venire in mente gli gnomi, i coboldi, le creature fantastiche di Ulisse Aldrovandi. Insomma, i “normali” erano solo i principi e le principesse, belli, ricchi e puliti nei loro castelli da favola. Gli altri erano caricature umane, o quasi, abitatori di grotte, tuguri, casupole. Proprio un’altra razza. Anche per questo, viva sempre la Repubblica.
Il 20%
Se un paese straniero aggredisse l’Italia e ne occupasse il 20%, cioè il Piemonte, la Lombardia e il Trentino Alto-Adige, oppure – a piacere – Sicilia, Sardegna e gran parte della Calabria, voi:
A) pensereste che tutto sommato non vi riguarda, perché voi non siete coinvolti;
B) andreste a combattere per riprendervi il territorio nazionale;
C) inviereste Matteo Salvini presso il nemico per trattare la pace;
D) issereste la bandiera del nemico e buttereste il tricolore, l’inno di Mameli, ecc.;
E) vi affidereste a ONU, UE per trovare un accordo (qualunque esso fosse);
F) portereste voi e i vostri cari in un altro paese;
G) altro (ci si augura un suggerimento).
Roberto Balzani