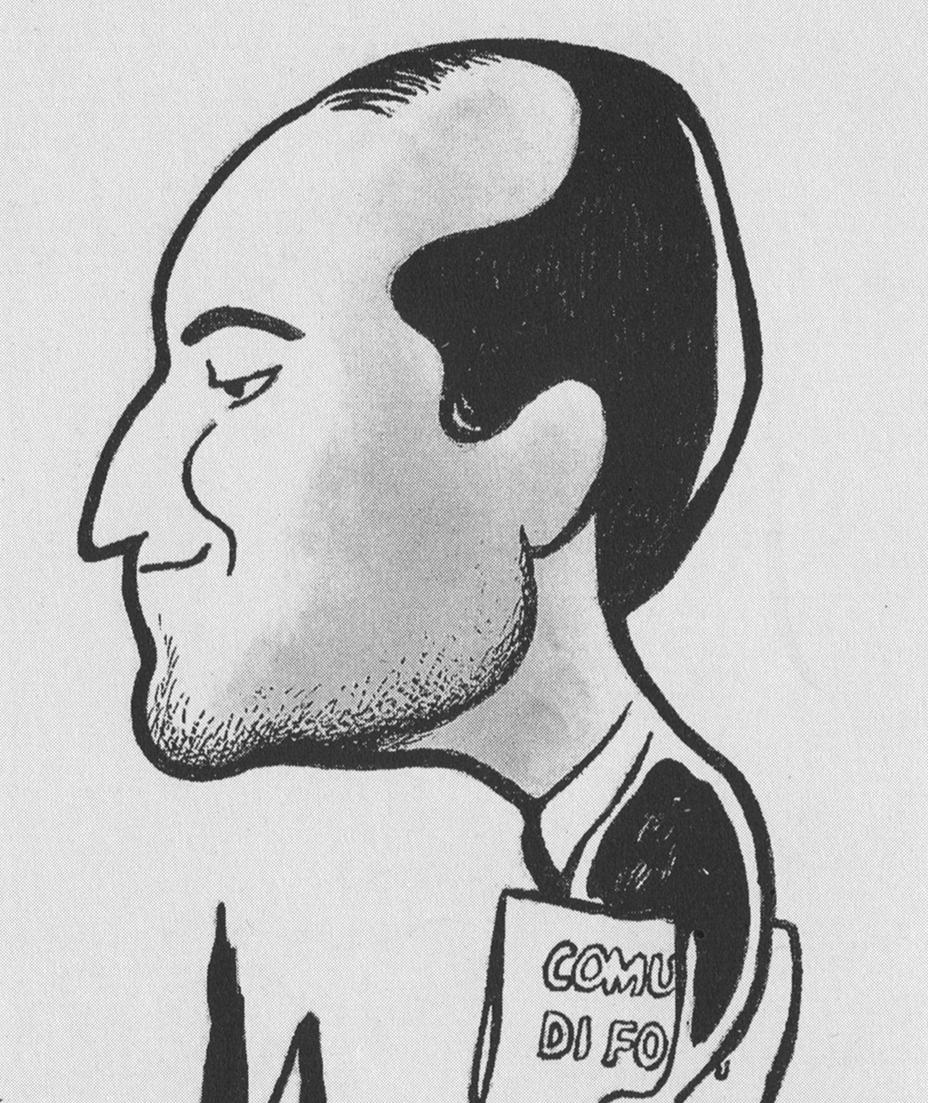Leggilo in 3 minuti
La doppia tomba di Luffo Numai

In piazza Morgagni a Forlì (nella foto) si trova la Chiesa di Santa Maria dei Servi, in Campostrino, più popolarmente conosciuta come Chiesa di San Pellegrino Laziosi. In seguito a saltuari contatti con la città, che alcuni documenti attestano sin dal 1271, l’Ordine dei Servi di Maria decise di stabilire anche a Forlì una sua sede. Inizialmente fu loro concesso di occupare un eremo nella contrada di Campostrino (o Campo Ustrino), luogo ameno, lontano dai clamori della città, che in epoca romana era destinato alla cremazione dei cadaveri e che nel Medioevo individuava una vasta area che si estendeva dall’attuale corso della Repubblica fino alla Rocca di Ravaldino. I religiosi occuparono una struttura religiosa già esistente e in stato di abbandono che, in segno di devozione, dedicarono a Santa Maria. L’edificio subì poi nel corso dei secoli innumerevoli rimaneggiamenti di cui non staremo a parlare in questa sede.
All’interno della chiesa, sul lato destro della controfacciata, si trova lo splendido monumento sepolcrale di Luffo Numai, scolpito nel 1502, caratterizzato dalle preziose raffigurazioni della Natività e della Resurrezione di Cristo, opera di due artisti lapidici di ambito lombardo, maestri nella lavorazione del marmo: Tommaso Fiamberti da Campione, attivo a Forlì anche in Duomo, e Giovanni Ricci da Sala Comacina. Il primo si occupò della parte architettonica, il secondo di quella figurativa.
Allo studioso Carlo Grigioni si deve il merito di aver pubblicato il testamento di Luffo Numai, in cui viene riportato con esattezza l’anno di realizzazione del monumento e la sua paternità.
Luffo Numai, letterato e potente uomo politico, nacque nel 1441 a Forlì, ove fu personaggio estremamente importante fin oltre la fine del Quattrocento. Seppe operare con grande diplomazia, barcamenandosi nel corso delle varie successioni al potere che si verificarono in quegli anni. Fu infatti prima consigliere di Pino III Ordelaffi, poi al servizio dei Riario Sforza, quindi sostenne Cesare Borgia. A riprova del trasformismo politico di Luffo e della moglie Caterina Paulucci restano i nomi che i coniugi vollero dare ai propri figli, scelti opportunamente in base a chi governava in città al momento della nascita dei piccoli. Infatti, quando a Forlì era al potere l’ultimo degli Ordelaffi, chiamarono il primo Pino, mentre a un secondo, nato durante la signoria dei Riario Sforza, imposero il nome di Girolamo, lo stesso del primogenito di Caterina Sforza.
Quando nel 1503 Giulio II della Rovere, il “papa guerriero”, ricongiunse Forlì sotto i domini della Chiesa, Luffo Numai pensò fosse arrivato il tempo per lui e per la sua famiglia di cambiare aria e di chiedere asilo ai veneziani a Ravenna, dove morì nel 1509. Negli ultimi anni della sua vita Luffo Numai commissionò la realizzazione di due monumenti funebri che vennero collocati uno a Ravenna nella stupenda Chiesa di San Francesco, il secondo, molto più rilevante, nella Chiesa di San Pellegrino a Forlì, per l’appunto.
Dopo la morte è molto probabile che le spoglie mortali del Numai siano state inumate prima nella tomba di Ravenna per poi successivamente essere trasferite in quella di Forlì. Tuttavia questa è solo una supposizione che resta tuttora da verificare.
La Rubrica Fatti e Misfatti di Forlì e della Romagna è a cura di Marco Viroli e Gabriele Zelli